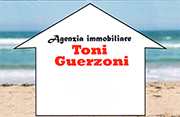L’abbazia di Pomposa è un luogo che non si può dimenticare, un piccolo gioiello medievale e magico, dall’atmosfera particolarissima e a volte desolata, ma che regala grande fascino.
Situata lungo la strada Romea nel comune di Codigoro, in provincia di Ferrara, e risalente al IX secolo, è una delle abbazie più importanti di tutta l’Italia settentrionale.
Storia
L’insula Pomposiana, conosciuta già nell’antichità, era in origine circondata dalle acque (del Po di Goro, del Po di Volano e del mare). Il primo documento storico che attesti l’esistenza dell’abbazia è del IX secolo: ne fa menzione il frammento di una lettera che papa Giovanni VIII inviò nell’874 all’imperatore Ludovico II.
Fino al XIV secolo l’abbazia godette di proprietà, sia nei terreni circostanti (compresa una salina a Comacchio), sia nel resto d’Italia, grazie alle donazioni; poi ebbe un lento declino, dovuto a fattori geografici e ambientali, quali la malaria e l’impaludamento della zona, causato anche dalla deviazione dell’alveo del Po (rotta di Ficarolo, 1152).
Ebbe una grande importanza per la conservazione e la diffusione della cultura durante il Medioevo, grazie ai monaci amanuensi che vi risiedevano. In quest’abbazia il monaco Guido d’Arezzo ideò la moderna notazione musicale. Nel 1653 papa Innocenzo X soppresse il monastero, che nel 1802 venne acquistato dalla famiglia ravennate Guiccioli. Alla fine del XIX secolo la proprietà passò allo Stato italiano. Il 18 maggio 1965 con la bolla Pomposiana Abbatia, papa Paolo VI concesse ai vescovi di Comacchio il titolo di abate di Pomposa; nel 1986 il privilegio passò agli arcivescovi di Ferrara-Comacchio.
Interno della basilica Santa Maria
Il nucleo più antico della basilica risale al VII-IX secolo; nell’XI secolo venne allungata con l’aggiunta di due campate e dell’atrio, e venne aggiunto l’atrio ornato di fregi in cotto, oculi, scodelle maiolicate, vari animali dal valore simbolico-religioso.
L’interno della chiesa è a tre navate, divise da colonne romane e bizantine. Il prezioso pavimento di marmo in opus sectile risale a varie epoche (dal VI al XII secolo) e presenta animali mostruosi, motivi geometrici, elementi vegetali e figurativi. Tra le allegorie il leone simboleggia la resurrezione di Cristo, il drago il male che è sempre sconfitto, il cervo è Cristo, gli uccelli con ali a riposo raffigurano la condizione umana. Sulle pareti affreschi trecenteschi di scuola bolognese, con storie dell’Antico Testamento, del Nuovo Testamento e dell’Apocalisse di Giovanni eseguiti rispettivamente sulla fascia superiore, mediana ed inferiore. Oltre a San Giovanni nell’estasi di Patmos, i quattro cherubini noti come i viventi del tetramorfo (Apocalisse 4, 6-8); i quattro cavalieri dai colori bianco, rosso, nero, verdastro con altrettanti attributi simbolici: corona, spada, bilancia, inferno. Sono poi presenti altre scene: Dio con il libro dai sette sigilli; i ventiquattro vegliardi; l’arcangelo Michele contro il demonio; la bestia dalle sette teste; l’idra che minaccia la Chiesa raffigurata come una figura femminile sicura poiché domina il tempo, cioè la luna posta ai suoi piedi (Apocalisse di Giovanni 12, 1-4). L’affresco del Giudizio Universale si distacca dalla trasposizione in figura dell’Apocalisse ed offre riferimenti espliciti al Vangelo di Matteo, mettendo così Pomposa in linea con le iconografie a partire dal XII secolo.
A destra del Redentore è raffigurata, con un preziosissimo abito ricamato in oro, la Vergine Maria che presenta l’abate committente Andrea mentre con la mano sinistra regge il cartiglio con la scritta “tuam fili clementiam”, raccomandazione per la comunità di Pomposa e per l’umanità. Nei dieci tondi del sottarco sono i profeti, divisi al centro da un angelo che reca un cartiglio con la scritta “Beati oculi qui vident quae vos videtis” (“Beati gli occhi che vedono le cose che vedete”), con riferimento alla visione celeste della gloria di Dio.
Campanile
Altissimo rispetto al resto dell’edificato (48 metri), il campanile è del 1063 in forme Romanico-Lombarde. Procedendo dalla base verso la sommità del campanile le finestre aumentano di numero e diventano più ampie seguendo una tendenza classica di quel periodo, che serviva ad alleggerire il peso della torre e a propagare meglio il suono delle campane. Dal basso verso l’alto sono presenti monofore, bifore, trifore e quadrifore.